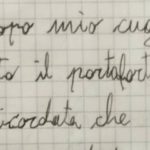
L’OCCHIO AZZURRO DELLA FORTUNA
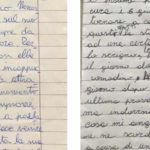
IL SEGRETO DI VIRGINIA
UN ANNO DI ENERGIA

Lasciare a Dante l’ultima parola non significa chiudere un argomento, né ritenere che non ci sia altro da dire, né tanto meno pensarsi ormai sufficientemente esperti per passare ad altro. La parola somma, quella del Sommo poeta, non è mai la parola ultima, perché essa spalanca al pensiero, non all’indottrinamento.
Per questo siamo soliti dedicare l’ultimo incontro dell’anno a una ripresa e insieme a un rilancio. Una ripresa perché, come in un braccialetto pieno di perline, recuperare il filo è il modo migliore per chiudere con un nodo la ricchezza accumulata. Un rilancio perché le cose imparate ci lasciano prima di tutto il compito di pensare oltre e di pensare meglio.
Lo facciamo ripercorrendo le parole che, di opera in opera, si sono aggiunte al nostro piccolo vocabolario dell’energia. Quando, otto mesi fa, abbiamo annunciato il tema, i ragazzi ci avevano sorpreso proponendo parole come «differenza, felicità, vita». Avevano intuito che non ci saremmo limitati a parlare dell’energia fisica e avremmo lasciato ampio spazio a quell’en- che ne caratterizza il nome stesso.
Rifacciamo da capo la strada del nostro gioiello, perlina dopo perlina. Abbiamo incominciato a distinguere i tre cammini che gli esseri umani hanno percorso per parlare di energia: il mito, la filosofia e la scienza. Nel primo abbiamo visto accrescersi i racconti di creazione: dall’energia come lotta (nei miti babilonesi) all’energia dell’eros (per i Greci), fino al gioco lieto della Sapienza (nel mito biblico).
Siamo poi passati alla filosofia, che cerca nel ragionamento quell’universalità che le storie dei miti non concedono. Abbiamo capito che da subito il pensiero filosofico affronta le paradossali tensioni tra episteme e doxa, mondo ideale e mondo delle cose; ci siamo appassionati ad Aristotele e alla sua idea del Sommo Bene come grande motore finale della storia: abbiamo riflettuto su come un grande desiderio possa permettere a chiunque di raggiungere le mete più ardite.
Infine, con il Galileo di Bertold Brecht, abbiamo seguito la svolta scientifica, dove l’essere umano può finalmente credere a ciò che vede e non ha bisogno di tutori o di sacerdoti che gli indichino la strada: la grandezza di Galileo è la sua capacità di rendere suo interlocutore persino il giovanissimo Andrea, suo garzone.
Il mito, la filosofia e la scienza non sono nemici, non si sono passati il testimone: chi voglia pensare può attingere alle grandi storie, alla profondità dei ragionamenti, al rigore dell’esperimento.
Ed è proprio con questi strumenti che incominciamo a guardare le diverse energie, cercando nell’esperienza quotidiana le più sorprendenti e, soprattutto quelle che più ci danno a pensare.
La prima è l’energia della natura. Con Leopardi abbiamo intuito che la natura non è costruita attorno all’essere umano, non ha noi come suo principale scopo: per questo non possiamo chiedere al mondo naturale e alla sua energia di rispondere del significato e del senso della vita. Quello, è compito nostro e nessuno ci può sostituire. Thoreau, uno dei fondatori dell’ecologia moderna, ha vissuto in un territorio di confine tra la natura e la cultura: non ha mai chiesto alla prima di guidare la seconda, ma di fungere da specchio critico del mondo culturale, perché gli umani potessero scorgere, nel contrasto con la natura, tutte le loro contraddizioni. La musica di Gershwin e il Jazz ci hanno introdotto a un’altra energia: quella della città moderna, cosmopolita e plurale, piena di contaminazioni feconde. Ancora la musica ci ha accompagnato sulla soglia di un altro tipo di energia: quella del corpo umano. Insieme a Tchaikovsky, sono state le statue di Rodin a riportare la nostra attenzione alla bellezza e alla forza del corpo umano. Proprio il corpo è stato messo in gioco dalla maggior parte dei ragazzi con il lavoro teatrale sul Vajont.
La testimonianza delle vittime di questa tragedia e la tenacia dei superstiti, che non hanno voluto abbandonare la loro montagna, è stato un esempio di un’energia particolare: quella dei deboli. Franz Werfel, nel suo testo I quaranta giorni del Mussa Dagh, dedicato alla resistenza degli armeni durante il genocidio, ci ha descritto questo genere di energia fin nei dettagli. È un coraggio inaspettato, nel quale corpo e mente si uniscono per far fronte all’ingiustizia. Una resistenza quotidiana, che trae forza dai gesti più piccoli e normali e che è in grado di smascherare la fragilità dei violenti.
Più misteriosa è l’energia che viene dall’amore, ma un grande amore dovrebbe potersi riconoscere proprio in virtù dell’energia potenziale in ogni amante che miracolosamente lo conduce là dove mai avrebbe immaginato, in un dispiegarsi di talenti che restano anche quando l’amore finisce: è vero amore, diciamo ai ragazzi, quando si diventa migliori. Così è la storia di Martin Eden, una sorta di alter ego dell’autore Jack London: l’amore di Ruth risveglia le migliori energie di Martin, gli permette di scoprire la sua strada, sebbene finisca per consumarlo irrimediabilmente. Così è anche la storia di Beren e Luthien, mortale lui, immortale lei, che dopo mille avventure che non si smetteranno mai di cantare, condividono con amore la condizione mortale e il limite che essa impone.
Dopo aver ripercorso il filo dell’anno, proviamo a guardare le parole si sono aggiunte e facciamo un bilancio del nostro vocabolario sull’energia. Ci accorgiamo che quelle che più sono ricorse sono due: tempo e cambiamento. L’energia più bella – ha ragione Dante – è quella che porta un essere umano a modificarsi, a migliorarsi, a trovare se stesso e il proprio posto nel mondo. Dante ci ha raccontato che non c’è nulla che allieti più di questo le anime del Purgatorio. Il tempo è la dimensione fondamentale del cambiamento: ti accorgi di essere cambiato proprio guardando indietro, scopri di dover dare a te stesso il tempo necessario per compierti. Ci commuove e ci riempie di orgoglio il fatto che la prima parola scritta sul nostro tabellone, quando ancora non avevamo altro che un tema da sviluppare, suggerita dalla giovane Lora, sia stata proprio questa: differenza.
