
IL VILLAGGIO DELLA CULTURA
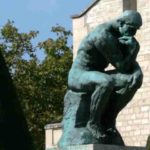
PENSATORI DEL CORPO…
IL BALLETTO: ENERGIA E GRAZIA

Quando parliamo di energia spesso, quasi istintivamente, pensiamo a qualcosa strettamente legato al mondo delle scienze.
Ciò che, erroneamente, ignoriamo è il fatto che tutto ciò che ci circonda ha una sua propria energia e che, a ben pensare, noi stessi siamo “energia”. Già dall’antichità, l’essere umano ha cercato e ideato diversi modi di liberare e dare forma all’energia interiore attraverso il proprio corpo, sviluppando movimenti, talvolta necessari e indispensabili come la corsa o la lotta, talvolta espressioni del desiderio o del bisogno di comunicare, senza parole, sentimenti come il timore e la reverenza nei confronti della divinità o delle forze della natura, l’amore, la passione, il dolore e lo strazio: così nasce, nel più naturale dei modi, la danza: i riti propiziatori, così come i riti funebri, le cerimonie di iniziazione, come le cerimonie nuziali da sempre trovano nella danza la loro massima espressività.
Abbiamo recentemente imparato come il coro greco al centro degli spettacoli teatrali greci non fosse un insieme di cantanti, come lo conosciamo ora, bensì proprio un corpo di ballo.
L’evoluzione del balletto, da una naturale e spontanea espressione corporea fino all’attuale forma di spettacolo che si basa su una precisa coreografia, creata a partire da una musica, ha inizio nel Medioevo.
Alle sue origini, il balletto era caratterizzato da costumi ampi e ingombranti che, più che promuovere l’espressione del corpo, creava movimenti minimi, piccoli passi, aggraziati ma non certo molto significativi. È solo con re Luigi XIV che il balletto si codifica con regole precise, grazie alle quali non rimane più solamente un lento disegno accompagnato da musiche, ma una vera e propria arte, il cui scopo è quello di comunicare leggerezza ed estraneità dalla dimensione reale.
Si balla sulle punte per ridurre al minimo la superficie di appoggio al terreno, si introducono i tutù che liberano le gambe e le braccia: il corpo torno a emergere e a esprimere la propria energia.
Voliamo fino alla corte del grande Tchaikovsky, il cui genio dona al mondo per la prima volta la bellezza generata dall’unione della danza, della musica e della passione. Del grande compositore analizziamo la drammatica favola Il lago dei cigni.
Attraverso quattro movimenti, così ricchi di musica e di energia che richiederebbero ognuno un articolo a parte, c’è la storia di una giovane, Odette, che, al principio della storia, sulla sponda di un fiume raccoglie un fiore. È qui che viene tratta in inganno e trasformata in un cigno dal mago Rothbarth con un incantesimo che, come nella più classica delle storie d’amore, potrà essere spezzato solo da un amore autentico ed eterno.
L’introduzione, suonata a sipario chiuso, allude al destino triste che incombe sopra i due amanti, e questa atmosfera è creata grazie a una scala discendente, che ritornerà in tutto il balletto. La storia continua nel primo atto in cui il principe Siegfried prepara i festeggiamenti per la sua festa. Pensieroso a causa della madre, che gli ha appena ricordato la necessità di trovare una sposa tra le principesse, decide di andare a distrarsi in compagnia dei suoi amici. Successivamente, con una balestra regalatagli dalla madre, Siegfried e i suoi amici decidono di andare a caccia nella foresta, dando inizio al secondo atto.
Ci troviamo sulle rive del lago al chiaro di luna, quando Siegfried e i suoi amici vedono sulle sponde quello che a loro sembra un gruppo di cigni, ma che in realtà è un gruppo di povere fanciulle vittime del malvagio Rothbarth. Qui il principe nota il più bello tra i cigni che, mentre sta per essere ucciso, si trasforma in Odette e rivela al ragazzo l’incantesimo subito dal crudele mago, spiegandogli che, per poter tornare alle sue sembianze umane, dovrà essere amata di amore eterno.
Il principe, ammaliato dalla bellezza della giovane, la invita ai festeggiamenti del giorno successivo ma Odette dichiara di non poter partecipare. Siegfried, addolorato dalla risposta della fanciulla, le promette che non sceglierà nessun’altra fanciulla. Intanto in sottofondo sentiamo il cupo Rothbarth che richiama Odette e le sue compagne.
Il terzo atto è aperto dall’entrata in scena della madre, seguita da sei fanciulle desiderose di diventare spose del principe. A un certo punto entra Rothbarth seguito dalla figlia, il cigno nero Odille, che con un incantesimo pare agli occhi di Siegfried identica a Odette. A distinguere le due fanciulle c’è il colore del costume, bianco per Odette, nero per Odille. Nel mentre, le sei fanciulle danzano alcune danze provenienti ognuna da diverse culture: una danza ungherese, una tarantella napoletana, una mazurka e una danza spagnola.
Odille e Siegfried danzano con passione, ad ogni passo Siegfried si innamora sempre più di lei fino a che, a un certo punto, decide di sposarla. Odille allora si lascia scappare una risata soddisfatta, facendo capire al principe di esser stato ingannato. Il principe allora, scorta la sagoma di Odette da una finestra, la insegue nella foresta. Odette piange disperata per il fatto che il principe non ha mantenuto la sua promessa e, quando lo vede arrivare, va da lui per dirgli addio: Siegfried le getta la corona nel lago. “Che hai fatto? Muoio!” gli dice Odette gettandosi fra le sue braccia e Siegfried decide di morire con lei, lasciandosi sommergere dall’acqua del lago durante la tempesta.
Si potrebbe raccontare nel dettaglio l’armonia della musica che, legata ai movimenti, dolci o impetuosi di Siegfried e Odette, dà vita a questo capolavoro. E ancor più a lungo si potrebbe discorrere sulle opere del geniale Tchaikovsky che, a parer mio, più di tutti i compositori è riuscito, grazie alla sua musica, a far capire che l’energia non è solo scienza. L’energia è anima e corpo. L’energia siamo noi.
