
CARO AMICO, TI SCRIVO

LA PIRAMIDE DEL CORAGGIO
L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELLA MUSICA (in collaborazione con Pinuccia Gelosa)
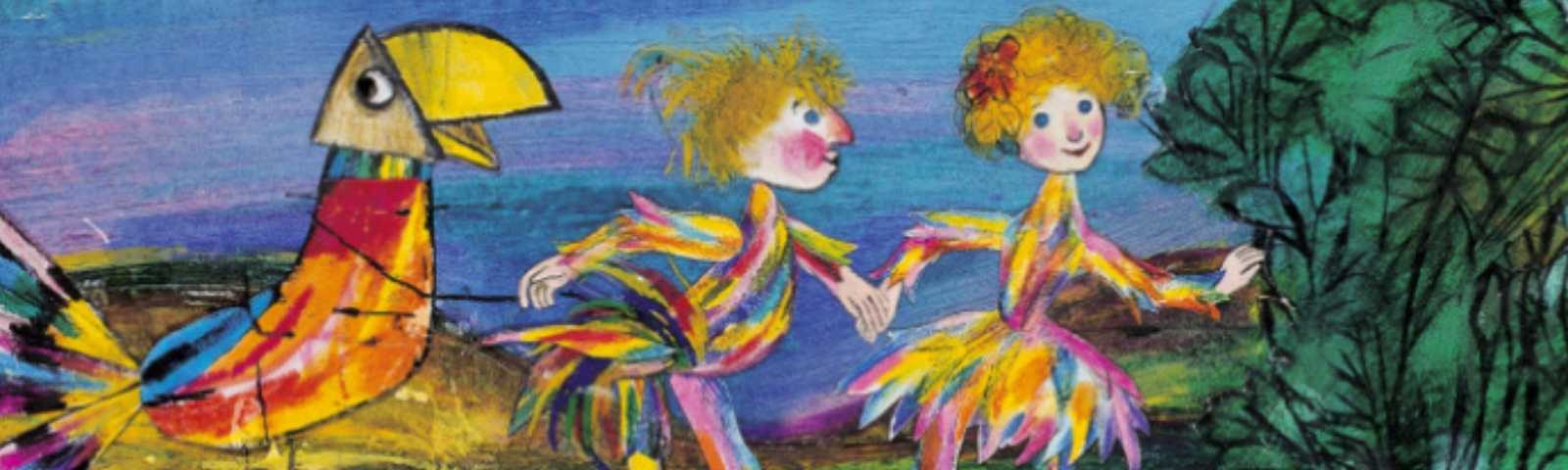
In nessun ambito, quanto nella musica, è possibile vedere realizzarsi un intreccio così stretto e ricco tra rigore e leggerezza. In nessun altro ambito le regole sono così importanti: presidiano il tempo e il ritmo, l’armonia e l’intonazione, l’unisono e il melodico. Basta pochissimo: una frazione di secondo, un movimento scomposto, un fiato in più di voce e la magia della sinfonia si spezza. Non è certo un caso che, nel nostro percorso sulla legge, quando dobbiamo spiegare cosa sia il bene comune, il più delle volte facciamo appello proprio all’immagine dell’orchestra.
Né è un caso che, ormai due anni fa, abbiamo introdotto la prima “guida all’ascolto” raccontando ai ragazzi la creazione fantastica del Silmarillion di Tolkien, pensata come una Grande Musica nella quale il male è anzitutto stonatura, mancanza di ascolto, confusione.
Certo, c’è musica e musica: ci sono le architetture barocche magnifiche di Bach, c’è il sentimento di Beethoven, c’è l’energia del Jazz e ci sono le eclettiche composizioni di Dorak che intesse musiche europee, africane e sudamericane. E, poi, c’è lui: Mozart, la più incredibile combinazione di rigore compositivo e leggerezza (a tratti quasi frivola) che sia apparsa nella scena umana.
Ci accompagna alla soglia del grande musicista Pinuccia Gelosa, che non è solo la nostra insegnante di pianoforte, ma anche una musicista impegnata da tanti anni nella direzione di musica d’insieme. Chi meglio di lei può spiegarci il mistero di una musica che, senza che nemmeno ce ne accorgiamo, è già nel repertorio di tutti? Non è solo l’uso che ne ha fatto la pubblicità commerciale: le frasi di Mozart si imprimono così profondamente nella memoria di ciascuno da darci l’impressione che fossero lì da sempre. I percorsi, a volte anche molto complessi, della loro melodia, sono così vicini a ciascuno di noi da apparirci naturali. Forse anche per questo un teologo diceva, alcuni decenni fa, che la grande musica di Bach è senz’altro la più adatta alla maestà delle liturgie ma che probabilmente, quando nessuno li ascolta, gli angeli in cielo canticchiano Mozart. Nato nel 1756 a Salisburgo in una famiglia numerosa, figlio di un violinista, il giovane austriaco già a sei anni passa la vita esibendosi nelle corti più importanti d’Europa, suonando il violino, l’organo, il pianoforte e impressionando chiunque per il suo talento quasi sovrumano.
Con una buona dose di coraggio, Pinuccia ci introduce a un’opera che, di questo intreccio tra rigore e leggerezza, tra norma e libertà, è la vera celebrazione: il Flauto magico. Si tratta non solo di un’opera – ossia di un intreccio tra racconto, canto e musica – ma anche dell’ultima scritta da Mozart, del suo capolavoro di maturità. Come spesso capita alle persone molto dotate, Mozart era piuttosto pigro e se abbiamo oggi il Flauto magico lo dobbiamo all’amico Schikaneder, che fu anche librettista dell’opera e che pare abbia convinto il maestro a suonare affittandogli un piccolo spazio accanto all’opera e nutrendolo a ostriche e vino.
Il racconto, di fantasia, ha una lettura piuttosto complessa. Non è, sebbene appaia, la storia consueta di un cavaliere che deve salvare la sua bella dalle grinfie di un mago cattivo. Gli elementi ci sono tutti, intendiamoci: c’è il principe Tamino, intrepido, c’è la principessa Pamina, prigioniera, c’è un carceriere crudele (Monostrato) e un signore cattivo che l’ha affidata a lui (Sarastro). Ma in questa strana storia, niente è come sembra: chi sia buono veramente e chi cattivo, per esempio, non lo scopriremo mai. Tutti i personaggi sono proprio come le musiche che li accompagnano: c’è bellezza anche nella tensione e c’è paradosso anche nell’armonia.
L’opera, come tutte le altre, alterna parti liriche, brani meditativi molto belli e talvolta molto complessi, le arie (affidate ora a un solista ora a un duo, ora a un piccolo gruppo di cantanti, ora al coro), a interventi narrativi, i recitativi, che hanno il compito di raccontare gli eventi o di guidare i dialoghi. In questo modo, ciascun personaggio viene caratterizzato non solo dal suo modo di vestire, ma dalla musica che canta.
Tamino, per esempio, ha un ritmo tutto suo, che lega le note al suo apparire o nei momenti di cui è protagonista. Proprio con lui si aprirà il sipario.
Il suo apparire è però proceduto, come in ogni grande composizione, da un’Ouverture strumentale che annuncia i temi più importanti e ci introduce al clima di fiaba: tre possenti accordi iniziali ripetuti tre volte e poi una fuga velocissima e quasi inafferrabile. Ecco qui il nostro tema: la solennità del numero perfetto, la severa possanza degli accordi, la durezza della pietra su cui è scritta ogni legge, compresa quella dell’armonia e il leggero svolazzo dello spirito della giustizia, senza il quale la legge è solo un monumento morto.
Forse non è un caso che, nonostante l’importanza di Tamino e della sua lotta coraggiosa per conquistare la povera Pamina, il vero protagonista dell’opera, quello che non si dimenticherà più, quello che ti si pianta in testa proprio come una melodia di Mozart (e proprio come la melodia che Mozart compone per lui) è un personaggio improbabile, un folletto un po’ matto: Papageno, l’uccellatore, il giullare di corte, colui che ha cura della voliera della potente e misteriosissima Regina della Notte, madre di Pamina. Pinuccia prova a spiegarci con ordine la trama, ma è talmente complessa che si stenta a ricordarla, come se non fosse la storia la cosa più indimenticabile, ma… altro. Quando, all’apertura del sipario, incontriamo Tamino, egli è assediato da un drago (di cui non sappiamo e non sapremo più nulla): coraggioso, resiste fino allo stremo. Papageno, che incontriamo poco dopo, è l’opposto: finge di avere ucciso il drago, si dà tante arie; capiamo subito che è solo un personaggio marginale, un buffone e che le cose importanti non spettano a lui. Anche gli oggetti magici che tre fate (le damigelle della Regina della notte) consegnano a ciascuno, la dicono lunga: un flauto magico a Tamino, un semplice Glokenspiel (una sorta di sonaglio) a Papageno. Eppure da subito qualcosa non torna: di fronte al flauto di Tamino, che ammansisce gli animali, il Glokenspiel di Papageno, che ipnotizza gli esseri umani, sembra essere dotato di una magia ben più potente.
La missione, in ogni caso, è chiara: Tamino deve liberare Pamina, a costo della sua stessa vita e poi, probabilmente, sposarla. Papageno accompagna, come una musica di sottofondo. Ma da chi deve essere salvata Pamina? Apparentemente dal suo carceriere Monostrato, violento e voluttuoso; ma forse dal padrone di Monostrato, Sarastro, un sacerdote potente e saggio. In tutti i casi, per liberarla, Tamino e Papageno devono superare delle prove e, si sa, le prove rendono migliori: il primo le passa tutte, l’uccellatore, nemmeno a dirlo, neppure una. Nell’intreccio appare anche la Regina della Notte, una donna bellissima, madre di Pamina, a cui è affidata una delle arie più famose e più difficili da eseguire di tutta la storia della musica: di fronte alle note, altissime, acuminate come pugnali (o forse come la luce delle stelle) non sappiamo se essere spaventati o innamorati.
Così è, in fondo, l’intera opera. Le arie che accompagnano i personaggi e li interpretano rimandano a una complessità che non può essere ridotta alle categorie con cui leggiamo le storie (bene e male, giusto e sbagliato). La musica è oltre, la musica è musica: irriducibile a un concetto, a una spiegazione, a un’idea, a una legge. La musica non è solo l’obbedienza alle leggi, ma quella passione che le genera. Non è il risultato dell’armonia, ma quel misterioso venire insieme delle note che ci ha insegnato a cantare.
Ecco, ora lo capiamo bene come mai è lui, Papageno, il personaggio che più ci ricordiamo e che maggiormente ci affascina. Perché, in fondo, la musica è proprio lui: quello zufolare così allegro da far fatica a prenderlo sul serio, quella letizia senza la quale, alla fine, non avremmo neppure incominciato ad ascoltare. Lui, che in fondo non vuole altro se non godere della vita, amare la sua Papagena, cantare con lei e mettere al mondo tanti piccoli Papagheni che, come delle note che cadono dal cielo, rigenerino per sempre la severa serietà degli eroi e delle loro leggi.
