
EPPURE LE STELLE NON SI SONO PERSE: LETTURA DI UNA GRAPHIC NOVEL
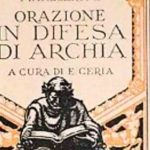
CITTADINANZA E CULTURA. RISONANZE.
LA CLEMENZA NON PUÒ ESSERE FORZATA

I personaggi che Shakespeare eredita dalla novellistica italiana sono per lo più delle caricature, degli stereotipi, quasi delle maschere. Lo spettatore, spesso, sapeva già cosa pensare di ciascuno di loro: la perfidia dell’usuraio, il coraggio del mercante, la bellezza della dama. Le storie, d’altra parte, non servivano per riflettere ma per intrattenere e, se una morale c’era, doveva essere semplice, accessibile e moralizzante. È proprio qui che il Bardo scompiglia le carte, trattando ciascuno dei personaggi come un essere umano, restituendo a ciascuno la profondità e la dignità di un’esistenza reale. Tutti sottolineano, giustamente, la fine introspezione psicologica di Shakespeare; ma egli insegna più di questo: mostra un senso di rispetto e di mistero per ogni vita, un senso molto alto della dignità. Ci ha insegnato che l’essere umano è proprio quella domanda che ha lo reso famoso, «essere o non essere», una domanda radicale e assoluta, una domanda che deve essere posta, per essere davvero umani.
Anche in questa commedia Shakespeare scombina le carte e lo fa nel modo più dirompente: anzitutto mettendo nella vita di Shylock il dramma di una figlia che fugge con un cristiano e poi, con un tocco di genio, mettendo sulle sue labbra un monologo che ha fatto la storia: «Non ha forse occhi un ebreo? Non ha mani, organi, membra, sensi, affetti e passioni? Non si nutre egli forse dello stesso cibo di cui si nutre un cristiano? Non viene ferito forse dalle stesse armi? Non è soggetto alle sue stesse malattie? Non è curato e guarito dagli stessi rimedi? E non è infine scaldato e raggelato dallo stesso inverno e dalla stessa estate che un cristiano? […] E se un cristiano fa un torto a un ebreo quale esempio di sopportazione gli offre il cristiano? La vendetta. La stessa malvagità che voi ci insegnate sarà da me praticata».
Con il monologo più memorabile dell’intera opera, il miracolo si compie: Shylock non è una maschera, ma un essere umano come noi. E la vendetta dell’ebreo non è altro che la nostra stessa vendetta, quella su cui il nostro mondo, che si crede civile, evoluto e caritatevole, decide le sue azioni e fonda la sua pretesa giustizia. L’avventura, dunque, prosegue come tutti ci aspettiamo, ma non possiamo più guardare all’usuraio come a un personaggio di carta: da questo momento è uno di noi.
La giustizia, dunque, dovrà fare il suo corso. Mentre Bassanio e Porzia, a Belmonte, finalmente si sposano (e così Graziano e Nerissa, servi di uno e dell’altra), mentre il patto d’amore è sugellato per entrambe le coppie con la consegna di due anelli che i mariti dovranno portare sempre con sé e custodire con la vita, a Venezia si organizza il processo per decidere il destino di Antonio. Informato, Bassanio si precipita a Venezia insieme a Graziano con 9.000 denari, per onorare il debito, nella speranza che l’ebreo accetti denaro al posto della carne di Antonio. Anche Porzia, di nascosto, fa lo stesso viaggio accompagnata da Nerissa; ma indossa un astuto travestimento per sostituire il giudice che dovrà fare giustizia e chiede anche a Nerissa di vestirsi da uomo e di impersonare l’assistente del giudice. Ancora una volta Shakespeare ci sorprenderà: la donna amata non è un ideale, ma un personaggio vero e proprio, astuto e geniale, che risolverà il dramma al posto degli uomini.
Il processo ha dunque inizio: il Doge lo presiede, Shylock pretende la carne di Antonio, il giudice avrà il compito di decidere. Compito difficile, perché un contratto è pur sempre un contratto e non rispettare le promesse metterebbe a rischio una città complessa e internazionale come Venezia. In un primo momento il giudice-Porzia prova a invocare clemenza, ma è consapevole che la misericordia non può essere comandata, può solo giungere come una pioggia celeste sulle vicende umane; Shylock non è certo disponibile e, sebbene lo avverta che, se ci fremiamo alla lettera della legge, siamo perduti, il giudice non può fermare la vendetta. Così, nonostante la brutalità della richiesta, non può che stabilire che l’ebreo ha diritto alla sua penale: «la legge e lo spirito della legge glielo consentono» e il giudice non può che convalidare la richiesta scritta. Eppure, mentre l’ebreo alza il coltello sul petto nudo di Antonio, giunge la salvezza: Shylock, dice Porzia, ha diritto a una libbra di sangue, ma non può versare neppure una goccia del sangue di Antonio, perché il contratto non lo prevede. Non solo, poiché ha attentato alla vita di un cristiano, egli perderà il suo patrimonio e la vita stessa; ma, poiché il giudice conosce la clemenza, la vita gli viene risparmiata e il suo patrimonio viene dato alla figlia Jessica, che era fuggita da lui e che ora dovrà occuparsi del padre.
Il lieto fine è dunque arrivato, grazie a una donna capace, con sguardo obliquo, di leggere ciò che, nella legge, va oltre la vendetta. Ma c’è un ultimo colpo di scena: Bassanio, ancora inconsapevole della sua vera identità, chiede al giudice di accettare un segno della sua stima e della sua gratitudine. L’occasione è perfetta per mettere in atto un nuovo paradossale intreccio: Porzia gli domanda l’anello che porta al dito e Bassanio non sa negarglielo, contravvenendo alla promessa fatta all’amata; ovviamente anche Graziano darà all’assistente del giudice l’anello di Nerissa. Un’altra promessa infranta, insomma, chiude la commedia; questa volta, però, è solo un gioco: dopo aver finto dolore e disappunto per il tradimento, presto Porzia e Nerissa svelano l’inganno e abbracciano i mariti per il vero grande finale.
I ragazzi sono colpiti e divertiti da questo racconto. E, giustamente, vi scorgono qualcosa di grande: in una trama apparentemente leggera, si è parlato di legge e di misericordia, di prestito e di impegno, di promesse fatte tra amici e di accordi fatti tra nemici.
Siamo tutti colpiti, per esempio, dalla frase di Porzia: la clemenza è l’apice della giustizia, eppure non può essere pretesa mai, non può essere imposta, nessuna legge può disporla dall’alto. Ci siamo anche chiesti se sia meglio chiedere prestiti a un amico o a un nemico, quando si è in difficoltà: da un lato l’amicizia con Bassanio costa molto ad Antonio, ma, dall’altro, il nemico Shylock non è capace di perdono. L’amicizia è un bene prezioso, ma non si può misurare anche perché, dice Lora, quando un amico viene meno a una promessa, oltre al bene concesso ne va di mezzo la fiducia, che è molto più preziosa. Forse, dice Thomas, un amico sarebbe più attento a gestire un prestito; Tiziano non è d’accordo, anzi sostiene proprio il contrario: un nemico incute timore ed è più facile prestare attenzione. Mattia, invece, un po’ come Shakespeare, sbaraglia le carte: l’aiuto concesso può trasformare un nemico in amico.
Certo, però, che il monologo di Shylock ci ha tutti colpiti: il personaggio peggiore, a un certo punto della scena ci dice: «sono proprio come voi». Riflettiamo molto su questa affermazione e ci chiediamo cosa ci sia dietro al male. Talvolta il desiderio di essere accattati da un gruppo, la voglia di sentirsi importanti entrano nelle nostre decisioni e ci portano a fare il male. In fondo anche un atto obiettivamente malvagio, come un furto, può avere delle ragioni: si può rubare per sfamare i propri bambini, per esempio. Le cose, allora, non sono mai così semplici. Spieghiamo ai ragazzi che nel medioevo si chiamava Pietas il rispetto e la compassione per le ferite dell’altro, anche per le ferite di chi non meriterebbe questo rispetto. Chiara dice che è una bellissima idea, ma che è difficile rispettare le ferite di chi non rispetta le tue. Lora è d’accordo, ma dice una cosa che sembra a tutti molto vera: sentire le ferite dell’altro non è questione di bontà o di volontà, ma di sensibilità. Una persona sensibile, queste ferite, le percepisce anche senza volerlo; e una persona buona, dopo averle sentite, se ne prende cura.
Ci chiediamo anche se le leggi si possono infrangere, in situazioni estreme. È molto bello che il primo nome che viene in mente ai ragazzi sia quello di Ghandi: una disobbedienza pacifica, pagata sulla propria pelle, senza alcuna violenza e senza rivoluzione è in grado di cambiare il corso della storia e di far scrivere leggi nuove. Aggiungiamo altri nomi: Martin Luther King, Mandela, Lorenzo Milani. Anche le promesse si possono infrangere, dicono, e spesso è persino più doloroso; però le promesse fatte tra persone che si vogliono bene, come per Porzia e Bassanio, possono sempre essere ripensate, risignificate, possono aprire nuovi cammini.
Un’ultima riflessione comune si apre sul tema della pena di morte: Shylock ha diritto alla libbra di carne ma non, dice il giudice, a spargere il sangue. Per fortuna, i ragazzi sono tutti d’accordo e tutti si indignano di fronte all’idea che si possa in qualche modo uccidere una persona. Tiziano dice che se uccidi un omicida, alla fine non sei diverso da lui. Lora è la più colpita da questo tema. Dice che la cosa più importante, per l’essere umano, è l’anima e che l’anima non si può toccare: si possono colpire i beni di una persona, si possono sottrarre alcune possibilità, ma nessuno ha il diritto di colpire l’anima.
Siamo felici di trovare in loro un consenso così compatto, soprattutto in un tempo in cui anche grandi nazioni democratiche ancora tollerano (o persino incoraggiano) la pena di morte. Forse, davvero, in questi ragazzi c’è il segreto della nostra speranza.
