
UNA STORIA CHE HA PER PROTAGONISTA “IL CATTIVO RENDIMENTO SCOLASTICO”
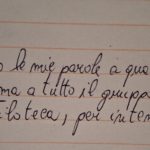
CARO AMICO, TI SCRIVO #2
MASSIMA FELICITA’, DIVISA SUL MAGGIOR NUMERO

Fra il marzo del 1763 e il gennaio del 1764, Beccaria scrive Dei delitti e delle pene. Racconta Pietro Verri che, dietro suo suggerimento, Beccaria cominciò a raccogliere “una gran folla di idee” sulla giurisprudenza criminale su pezzi di carta volanti che, discusse e approfondite dai focosi accademici dei Pugni durante le passeggiate dopo pranzo, venivano poi fissate e ordinate dal marchese durante le serate in salotto.
L’editio princeps fu pubblicata a Livorno nel luglio dello stesso anno in forma anonima, per evitare ripercussioni e la sua immediata fortuna ha dello straordinario, se si considerano i mezzi dell’editoria e della diffusione dei libri del tempo. Attaccato immediatamente dal monaco Facchinei che ne denunciò l’empietà, il saggio fu difeso con forza dai fratelli Verri; nel 1766, la quinta edizione — considerata l’edizione italiana definitiva — fu tradotta in francese e, messa all’indice a febbraio, pochi mesi dopo poté gloriarsi dell’appoggio del Commentaire di Voltaire. Già nel 1766, ispirata dal saggio di Beccaria, la zarina Caterina II istituì una commissione per redigere un nuovo codice di leggi per la Russia, ma la traduzione in russo si diffuse anni dopo, nel 1803. Nel 1767 videro la luce le edizioni inglese e tedesca, nel ’68 quella olandese e nel ’74 la spagnola. Il saggio divenne danese nel 1796, greco nel 1802 e i suoi principi comparvero nel Codice penale napoleonico e in quello austriaco. Commuove che nella nostra stessa Costituzione se ne avverta chiaro il respiro. Ancora oggi, l’opera di Beccaria è custodita a Milano, nella Biblioteca Ambrosiana.
Tanto, della fortuna dell’opera, si deve al fatto che Beccaria si sia da subito sentito parte di un grande movimento di pensiero e non abbia mai voluto emergere personalmente: più volte, nell’opera, si dichiara debitore di Montesquieu, Helvétius e dei grandi teorici dell’Illuminismo. Eppure lui, personalmente, è mosso da una profonda passiona morale, da un grande senso di solidarietà nei confronti di chi subisce l’ingiustizia, da una indignazione contro le leggi barbare che ancora vigevano in Europa, nonostante il secolo dei lumi. Per questo, pur nella razionalità dei suoi ragionamenti, quasi matematici, Dei delitti e delle pene è un’opera attraversata da un grande spirito di umanità e senso di giustizia.
Forse è proprio questa una caratteristica di quell’Illuminismo lombardo che seppe raccogliere diverse correnti di pensiero e accompagnare il trionfo della ragione con la potenza del cuore. Per rispondere coerentemente a questo movimento di pensiero, con i ragazzi leggiamo i paragrafi più rilevanti (e forse i più difficili) e ne facciamo immediatamente oggetto di dialogo: testa e cuore, da noi, procedono sempre insieme.
Per la prima volta, in questo anno ad essa dedicata, troviamo una definizione di legge: «le leggi sono le condizioni con le quali uomini indipendenti e isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall’incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità». Già solamente per incominciare a discutere, abbiamo immaginato che ciascuno dei ragazzi, seduto attorno al nostro grande tavolo, deponga al centro un po’ della sua libertà: ne risulta un piccolo patrimonio di libertà che noi, responsabili, dobbiamo custodire. Chi lo violasse, commetterebbe un reato e incorrerebbe in una pena.
Siamo molto lontani dalle figure simboliche dell’antichità: dalla dea della giustizia, dal patto con l’Eterno e persino dalle immagini del Buon Governo, pur così vicine, nella storia, all’Illuminismo: «non bisogna attaccare a questa parola giustizia l’idea di qualcosa di reale come una forza fisica o un essere esistente», scrive Beccaria. E non bisogna neppure immaginare che un unico sovrano detenga tutti i poteri, come nell’allegoria di Lorenzetti. La pena è affare della legge, ma la legge è affare esclusivamente del legislatore, non del sovrano, che si trasformerebbe altrimenti in tiranno.
Ciò che più spiazza i ragazzi, tuttavia, è il preciso rifiuto di un’idea che ci ha accompagnato fino a qui. Il paragrafo IV è dedicato all’interpretazione delle leggi e Beccaria dice: «non vi è cosa più pericolosa di quell’assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge». I ragazzi, giustamente, si stupiscono: non è proprio di questa distanza tra la legge e il suo spirito che, fino ad ora, abbiamo parlato? Non lo abbiamo ritrovato sempre, da Hammurabi fino a Shakespeare?
La risposta sta nella netta separazione che Beccaria, insieme a tutto l’Illuminismo, pone tra la realtà e le sue interpretazioni: i grandi temi della giustizia spirituale e religiosa rischiano di diventare alibi per non raggiungere quella giustizia umana che è tanto necessaria. Non si può legare il destino di una persona all’«animo fluttuante» di qualcun altro. Ciò non significa stupidamente accettare qualunque norma, ma pretendere che una norma sia scritta in modo da non creare alcuna ambiguità e rendere superflua l’interpretazione. Chiediamo ai ragazzi come debba essere una simile legge. Viola dice che ci vuole precisione, ossia la capacità di definire senza sbavature la situazione che si vuole normare. Tiziano aggiunge che è necessaria la chiarezza e, soprattutto, l’equità: se i concetti non sono espressi in modo univoco, non si potrà mai fare a meno dell’interpretazione. Thomas, infine, ricorda che fin dall’inizio del nostro percorso la legge è necessariamente scritta.
l paragrafo V – Oscurità delle leggi – dice: «quanto maggiore sarà il numero di quelli che comprenderanno e avranno fra le mani il sacro codice delle leggi, tanto meno frequenti saranno i delitti, perché non v’è dubbio che l’ignoranza e l’incertezza delle pene aiutino l’eloquenza della passione».
Certo, non ci illudiamo che sia sufficiente una legge ben scritta. Beccaria stesso dedica un paragrafo agli Errori nella misura delle pene. Ascoltandolo, il dibattito si infiamma: da un lato egli ha ragione quando sostiene che non si può «scrivere una legge per ciascun cittadino e per ciascun delitto». D’altra parte, ricordiamo ai ragazzi l’idea di Lorenzo Milani secondo cui «non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra disuguali». I due estremi sono ben presenti ai ragazzi, che si schierano ora con uno, ora con l’altro. La scuola è teatro di ingiustizie continue, dicono alcuni, di favoritismi che i ragazzi talvolta subiscono, ma talvolta ricevono a proprio favore e ne sono pienamente consapevoli. Matilde, per esempio, racconta divertita che la sua professoressa, rigorosamente assegna 4 a chi non presenta un compito; l’unica volta che si è resa colpevole di questo reato lei, solitamente precisa e diligente, la professoressa ha posticipato la data di consegna del compito. Matilde, già pronta a ricevere una nota sul diario, si è sentita ingiustamente favorita.
Come sempre, piovono commenti sulle agevolazioni di cui godono i tanti ragazzi certificati o sulle manifeste indulgenze nei confronti di compagni con comportamenti maleducati e non facilmente arginabili: Chiara, Lora e Mattia sembrano appartenere a un girone infernale più che a una classe di terza media…! Lora racconta che, per una tombola, ciascuno doveva portare un piccolo dono: terribile la differenza fra la cura di alcuni che hanno comprato un oggetto bello e utile e lo hanno persino impacchettato con attenzione e chi, con spregio, ha gettato sul banco una moneta da 1 euro, avvolgendola in un pezzo di carta…
Cerchiamo di portare la riflessione dei ragazzi sul perché l’aiuto – più o meno meritato, più o meno consono – dato a un compagno li faccia sentire depredati del loro e diminuiti, pur consapevoli di quanto questo tema dell’ingiustizia subita in paragone a un altro, accompagni l’uomo in ogni sua età e sia causa di sofferenze e rabbie anche in ambito lavorativo.
«Se tu hai ricevuto quanto meritavi e ne sei soddisfatto, non ha importanza cosa abbia ricevuto l’altro. Più ampio è il numero dei ragazzi coinvolti nel bene, meglio è per tutti», spieghiamo ai più indignati. Non è certamente facile comprenderlo.
L’apice del pensiero di Cesare Beccaria è racchiuso nella celeberrima formula «la massima felicità divisa nel maggior numero» con cui il filosofo sintetizza, nell’introduzione al suo saggio, l’obiettivo principe della legislazione e della giustizia umana: non una vana utopia, perché il superlativo è relativo e non assoluto, ma un concreto risultato cui tendere. Siamo ancora molto lontani dal raggiungimento di tale risultato, anche nelle scuole dei nostri piccoli e focosi accademici, ma abbiamo la speranza che dialogare su temi tanto importanti eserciti la mente e il cuore a guardare la vita da angolature nuove e diverse, con quello sguardo obliquo che Matilde, davanti a un pubblico estasiato, ha dichiarato di imparare in Piccioletta barca.
