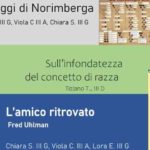
“REUNION”, PIU’ FORTE DELLA MORTE È L’AMICIZIA

MUSICA, MAESTRO!
LE PAROLE SONO IMPORTANTI

Non abbiamo, in Piccioletta barca, un analista o un esperto di politica internazionale e nessuno di noi è in grado – ammesso che qualcuno, oggi, lo sia – di leggere con sicurezza ciò che sta accadendo in queste settimane nella scena globale. Assistiamo, come tutti, alla lenta e inesorabile caduta dei riferimenti che, nei decenni passati, ci hanno permesso di capire qualcosa: è come se scomparissero gli assi cartesiani che ci permettevano di prendere le misure con il grande mondo della geopolitica. Leggiamo, come molti, analisi e contro-analisi e ci ritroviamo in un inedito stato di incertezza: firme stimate sostengono posizioni diametralmente opposte sull’Ucraina, sugli Stati Uniti, sulla tragedia della Palestina e di Israele. La complessità del mondo non è mai stato un concetto così tangibile. Altrettanto tangibile è la percezione che, in questo modo, ne vada dell’idea stessa di verità, della pretesa stessa che una qualche verità effettivamente esista. Proprio ieri, parlando di legge con i ragazzi, uno di loro ha avanzato l’idea che non esista un confine netto tra il bene e il male perché, in fondo, alcune persone possono chiamare male ciò che altri ritengono essere un bene. Affermazioni come questa non possono essere prese sottogamba, perché un giovane convinto di non aver titolo per distinguere il bene dal male diventa facile preda di chi voglia approfittarne.
Rispondere a questi ragazzi ci chiede di assumere una postura quasi impossibile: non possiamo dare ai ragazzi giudizi affrettati su scenari complessi, ma non possiamo neppure tacere. Tacere, in effetti, ci pare essere diventata la tentazione di tanti adulti. Degli adulti buoni, quelli intelligenti, quelli che rifiutano il contrasto delle opinioni, dei discorsi da bar, del tifo da stadio o da tastiera che sembra appassionare tutti gli altri. Come se l’alternativa al grido fosse il silenzio, la parola soffocata, la resa. Alcuni ragazzi ci hanno raccontato, per esempio, che quest’anno la Giornata della Memoria è trascorsa nel silenzio, così come la Giornata contro la violenza sulle donne, qualche mese fa. Difficile biasimare troppo gli insegnanti: questi temi sono diventati divisivi, meglio rifugiarsi nella trigonometria o nella cara vecchia fotosintesi clorofilliana. Invece, tacere non si può. Parlare di ciò di cui non si può parlare, talvolta, non è solo un’opzione: è un compito. Per farlo, in queste settimane, abbiamo trovato due alleati, che vi vorremmo presentare.
Il primo alleato è il linguaggio. Non sappiamo esattamente quali reali scelte politiche si nascondano dietro alle minacce del presidente o del dittatore di turno: c’è chi le ritiene solamente parte di un grande gioco politico, una strategia comunicativa. Ma sappiamo che le parole, i gesti, gli slogan hanno un effetto immediato nel discorso comune e, soprattutto, nella mente di un giovane in ascolto. Che la parola deportazione sia entrata da alcuni mesi nel discorso di un paese democratico, che la parola ritardato venga difesa da un uomo politico come un diritto o che circoli un video in cui un intero paese – un paese dove vivono due milioni di uomini, donne e bambini – viene trasformato in una sorta di Las Vegas… tutto questo ha già un effetto. È già successo, ha già superato la membrana dell’ascolto e dello sguardo, è già entrato nei loro cuori: le bombe che cadono attorno a noi non producono (ancora, fortunatamente) crateri nelle città, ma nel discorso comune aprono voragini. Per questo non si può tacere. Avere come alleato il linguaggio significa ricordare ai ragazzi che la scelta di non pronunciare alcune parole ha avuto un prezzo molto alto. Per esempio, la scelta di rigettare il fascismo – come è scritto nella nostra Costituzione – è costata milioni di vite. La scelta di non far coincidere una persona con la sua disabilità (handicappato, ritardato, imbecille) è costata l’impegno di generazioni di uomini e di donne che, come Franco Basaglia nel nostro Paese, hanno speso la vita a combattere i pregiudizi più radicati. La scelta di non ridurre la politica alla legge del più forte è costata due secoli di storia italiana, nel passaggio dal feudalesimo all’epoca dei Comuni e poi, di nuovo, molti altri secoli di storia europea e mondiale. «Le parole sono importanti», urlava a bordo di un’improbabile piscina il protagonista di Palombella rossa (Nanni Moretti, 1989), «chi parla male pensa male». Anche i gesti sono importanti: quando ero bambino, per andare in Francia dovevo cambiare la moneta e preparare il passaporto; oggi mi basta prendere l’auto: anche questo ha avuto un costo. Le parole sono importanti e, proprio quando le situazioni sono confuse, dedicarsi alle parole è una forma infallibile di resistenza. Durante la più grande crisi dell’Occidente, dopo la caduta dell’Impero romano, un gruppo sparuto di uomini e donne, nei monasteri, ha dedicato la vita a salvare le parole dall’oblio. Forse noi possiamo farlo con una spesa minore: un po’ di attenzione per riconoscere il bene che ci circonda, un po’ di tempo per ascoltare, un costante dialogo con noi stessi e poi il coraggio di dire la nostra opinione, senza gridarla in faccia a nessuno.
Il secondo alleato, formidabile, sono i ragazzi. Troppo spesso finiamo per immaginare che l’educazione sia anzitutto affidata alle nostre abilità comunicative, alla chiarezza delle nostre idee, alla capacità di stupirli. Non è così: al cuore di ogni relazione educativa ci sono anche loro, con la loro sensibilità, la loro intelligenza, la loro voglia di capire meglio. E con il loro bagaglio di esperienze da portare, sempre. Il confronto tra le idee di un libro e la vita quotidiana non è una strategia per far comprendere meglio le lezioni o per attualizzare teorie del passato: è il luogo reale in cui i nodi apparentemente inestricabili della realtà incominciano a sciogliersi. A chi, ieri, sosteneva che la verità non esiste, abbiamo chiesto come mai, allora, tutti piangiamo per la morte di una persona cara o ci innamoriamo, tutti sperimentiamo la gioia o la noia, la bellezza di un’amicizia o la solitudine. Alla fine del discorso il ragazzo era convinto, non da noi, ma da ciò che la sua giovane vita ha già scritto, indelebile, in lui. Avere i ragazzi come alleati significa anche concedersi il lusso di dire loro che non abbiamo tutte le risposte, ma che possiamo provare a cercarle insieme, perché così gli esseri umani hanno sempre fatto, ogni volta che si sono trovati di fronte alla sproporzione del compito della storia. Significa confessare loro che non abbiamo chiaro il futuro del nostro piccolo centro culturale, ma che non sarà senza di loro.
Non ci è mai capitato che, di fronte a questo, qualcuno protestasse, si scandalizzasse o si dimostrasse disinteressato. Soprattutto, non ci è mai capitato di tornare a casa senza la certezza che, grazie a loro – alla faccia di chi vuol convincerci che il bene e il male non esistono – riusciremo a capirci qualcosa anche noi. E che, per noi, farlo insieme a loro è la cosa più importante.
