
A QUATTRO MANI CON KAFKA
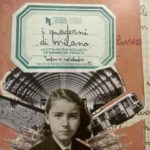
I BAMBINI SONO LA STORIA: MUSEO DEL QUADERNO A MILANO
RIPENSANDO A FRANZ KAFKA
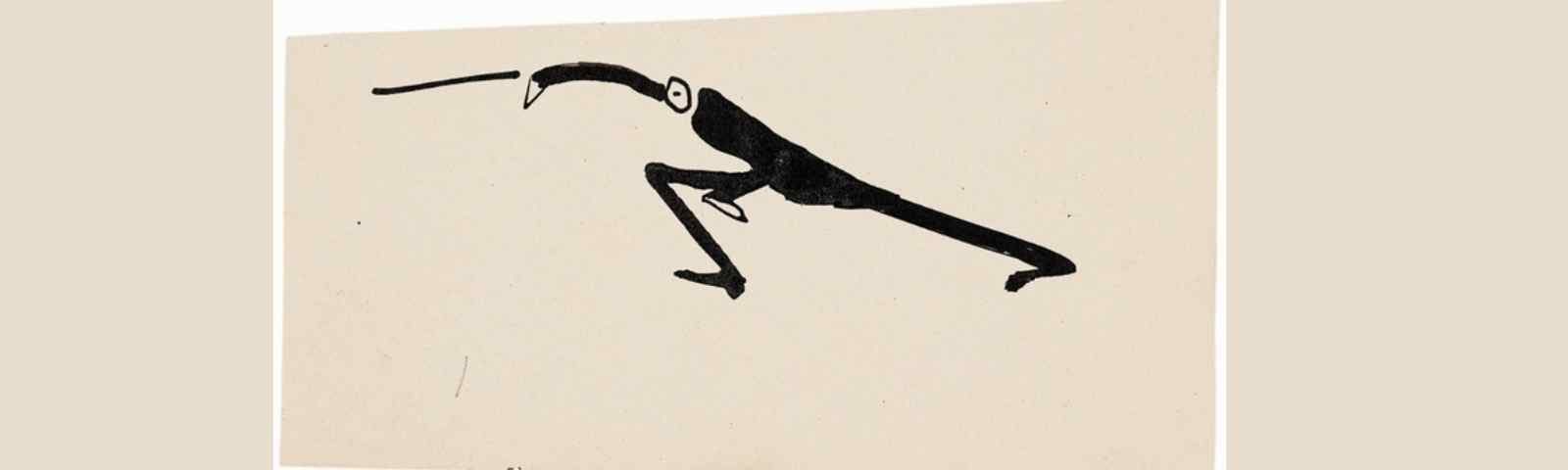
Ciò che in genere provano i lettori di Kafka è una fascinazione vaga e generica, anche per storie che non riescono a capire, un ricordo preciso di immagini e di descrizioni strane e apparentemente assurde; finché un giorno il significato nascosto si rivela loro con l’evidenza improvvisa di una verità semplice e incontestabile.
Scrive così Hannah Arendt, di cui i ragazzi non potranno non ricordare almeno il nome, data la frequenza con cui il suo acuto pensiero ci accompagna in Accademia. Lo scrive in un breve saggio dedicato allo scrittore boemo, in occasione del ventesimo anniversario della sua morte.
Partiamo da questo pensiero perché, effettivamente, ci siamo accorti quanto, sabato scorso, il racconto della scarna trama del romanzo e la lettura di ampi brani del libro abbia incatenato i ragazzi. Uno di loro, il lunedì successivo, uscendo dalla sede, dopo un altro incontro, ci ha proprio detto quanto gli fosse piaciuta quella lettura. Alcuni ragazzi di seconda e prima media avevano già conosciuto Kafka grazie al fulmineo e folgorante racconto Lascia perdere!, di cui erano stati invitati a scrivere, in pochissime righe, una possibile conclusione. Cinque ragazzi, cinque finali diversi: forse non è vero che i ragazzi si rifugiano nel pensiero del compagno di banco, accordandosi con l’ultimo intervento ascoltato…
È questa la magia – una delle magie – di Kafka: spalancare e non chiudere, quasi che la mancanza d’aria e la claustrofobia patita da Josef K. nei meandri del tribunale, dal signor K. nelle stanze del castello, da tantissimi altri personaggi dei suoi racconti, quella stessa mancanza d’aria e quella claustrofobia che proviamo noi lettori, attratti e respinti dalle sue pagine mentre le divoriamo, facessero da contraltare all’impossibilità assoluta di ingabbiare Kafka in una corrente letteraria, in un movimento, in una tendenza, in una chiave di lettura univoca.
Prendiamo Il processo: parabola di una ricerca religiosa, sconfinante nella disperazione e nell’ateismo, secondo la critica spiritualista; immagine distorta e efficace della società capitalistica, non fatta a misura dell’uomo, oppressiva e alienante, secondo la critica marxista; espressione figurativa del mondo inconscio, con i suoi sogni e i suoi complessi, secondo la critica psicanalitica; confessione dell’uomo colpito da malattia mortale e tagliato fuori dal mondo, secondo la critica medico biografica. Tutto oppure niente di questo: chi ha patito tutta la vita gli angusti confini di una minoranza, di una famiglia, di un ufficio non lascia che la sua opera sia confinata da una etichetta.
Uno sguardo alla biografia dell’autore permette di accostarsi a lui con le dovute maniere; nato a Praga nel 1883, Kafka non fa parte della maggioranza boema, ma di ben due minoranze: è tedesco di lingua e ebreo di religione, cosa che crea in lui un costante senso di isolamento e disagio. Praga è una città culturalmente vivace e ricca. Con il padre, fattosi dal nulla e agiato commerciante con negozio di moda in centro città, l’incomprensione è totale e il dolore di Franz sfocia in quell’opera capitale che è Lettera al padre, mai consegnata al genitore, la cui lettura è, forse, passaggio fondamentale di ogni figlio. Franz è gracile e debole; dopo il liceo vorrebbe andare a Monaco a studiare germanistica e invece deve restare a Praga dove frequenta legge (!!). Laureatosi, diventa un grigio impiegato presso l’Istituto di Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e questa triste carriera sarà distruttiva per l’uomo, ma fucina di idee e immagini per lo scrittore. L’unico respiro per Kafka è l’attività creativa che deve però relegare alle sole ore notturne. Mentre i pochi amici lo dipingevano come uomo di estrema cortesia, generoso e grande conversatore, Franz di sé diceva di essere chiuso, taciturno, poco socievole e lo diceva con estremo astio nei propri confronti: «Odio in modo assoluto tutti i miei parenti, non tollero la convivenza con gli uomini; tutto ciò che non è letteratura mi annoia». Kafka, incapace di un rapporto amoroso sano e duraturo, torturato dall’insonnia, angosciato dalla realtà enigmatica che lo circonda, consumato dalla tubercolosi, muore in sanatorio a Vienna a soli quarant’anni. È solo per iniziativa dell’amico Max Brod che i romanzi di Kafka vengono pubblicati: secondo la disposizione del loro autore, avrebbero dovuto essere bruciati dopo la morte.
Ecco tracciato brevemente per i ragazzi il contesto esteriore e interiore in cui inserire la nuova opera del nostro percorso sulla legge. Non vola una mosca: questo Kafka, pur inquietante, calamita a sé l’attenzione di tutti.
Con la medesima attenzione, è tempo di interrogarci insieme sul testo. La prima grande domanda, che non può non attraversare qualunque lettore, è se K. sia, in realtà, colpevole o innocente. Nicolas e Mattia, fratelli, hanno interpretazioni opposte: per il primo K. non può che essere colpevole, perché si comporta da tale; per Mattia, invece, è innocente, proprio perché appare del tutto disarmato di fronte al dramma che sta vivendo. Milan Kundera, probabilmente, sarebbe d’accordo con entrambi: K. è «un uomo colpevolizzato», cioè reso colpevole dal processo stesso. D’altra parte, la colpevolezza è difficile da separare dal senso di colpa, che è uno dei sentimenti più forti e misteriosi dell’esperienza umana. Matilde racconta di come, talvolta, i professori facciano sentire intere classi in colpa, per dinamiche e atteggiamenti che essi leggono in modo unilateralmente negativo. Gabriel porta l’esperienza dell’amicizia: capita che un amico, per le più disparate ragioni, sia ombroso e taciturno e lui, subito, si chiede se non sia responsabile di questa tristezza. Restando nel medesimo ambito, Samuele pensa che spesso chi entra per la prima volta in un gruppo si sente a disagio e, se il disagio continua, può percepire la sua inadeguatezza con un profondo senso di colpa. Il senso di inadeguatezza che si moltiplica misteriosamente quando si è di fronte a una persona in divisa, resta, indubbiamente, un’arma molto potente per controllare le persone: qualche volta anche le religioni (con le loro specifiche divise) lo hanno usato per soggiogare gli animi.
Cosa, più di tutto, impaurisce, in una situazione come quella di Joseph K.? Matilde, che forse ricorda vividamente la lettura di Cesare Beccaria, sostiene che il primo elemento che spaventa è proprio la pena; Chiara, una delle ragazze che hanno recentemente lavorato sulle leggi razziali, ammette che chi amministra la giustizia, con tanto di polizia e di deterrenza, è sempre più forte; quindi, ha sul reo potere di vita o di morte.
Resta il fatto che, nel Processo, la giustizia è amministrata non tanto da persone, ma da una sorta di grande macchina. Ci sembra opportuno confrontare questa distopia con l’ambizione di Beccaria di razionalizzare la giustizia: certo, nel caso dell’Illuminismo la razionalità è garanzia di imparzialità. Tuttavia, il rischio che Kafka intravede è che si generi a lungo andare una disumanizzazione della giustizia. Viola sostiene che un meccanismo razionale è oggettivo e non può mai essere di parte, là dove una persona che amministra la legge può, invece, diventare arbitraria; ma Gabriele ricorda a tutti che un meccanismo non può vedere, per esempio, il percorso di pentimento e di riscatto che una persona colpevole può avere compiuto, nel tempo.
Forse, però, Kafka non ci sta offrendo tanto un discorso teorico sulla giustizia, quanto un’immagine che, come diceva la Arendt, è destinata a restare nella mente e, pian piano, a svelare la sua verità. Per questo concludiamo chiedendo ai ragazzi quale delle opere lette finora richiami il Processo di Kafka. Gabriel pensa al Mercante di Venezia, perché c’è anche lì un processo che muove da pretese assurde e angoscianti (una libra di carne); anche in Shakespeare c’è un avvocato e un tutore che concede i suoi denari (Porzia, in entrambi i casi). Matilde e Emma pensano subito ad Antigone, perché nella tragedia, come nel processo, non si riesce a dipanare mai chiaramente il discorso della giustizia e della responsabilità. Mattia e Thomas, invece, hanno pensato all’allegoria del cattivo governo di Lorenzetti, dove un sovrano strabico amministra l’ingiustizia, a partire da una struttura istituzionale apparentemente identica a quella del Buon governo. Certo, Tiziano, ha ragione nel confrontare il povero Joseph K. agli ebrei che, senza alcuna colpa e motivazione, finivano negli ingranaggi del Reich.
Segno, tutta questa ricchezza di interpretazioni, che davvero l’immaginario di Kafka parla una lingua comune che intercetta in tanti modi diversi l’esperienza profonda di ciascun essere umano.
