LETTURA AD ALTA VOCE: DALLA DIDATTICA A RITO COLLETTIVO
LE PAROLE SONO IMPORTANTI
UTOPIA: LA GIUSTIZIA E’ LOTTA ALL’INDIFFERENZA
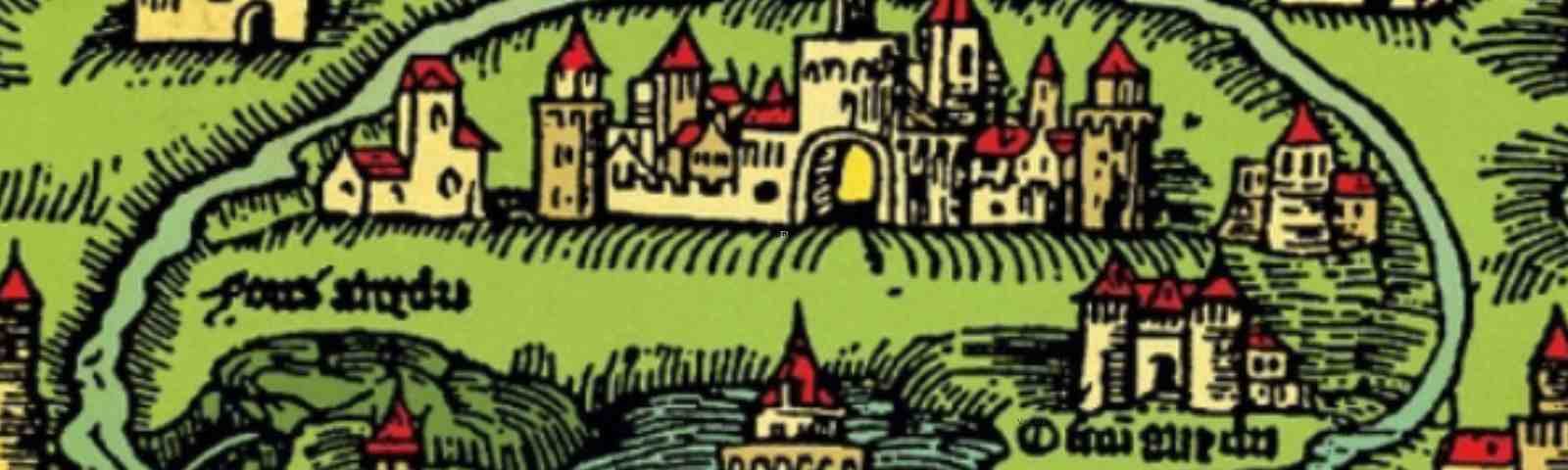
Ripercorriamo insieme ai ragazzi le caratteristiche fondamentali dell’isola di Utopia, che emerge dalle acque dell’oceano fra vecchio e nuovo mondo, ed è bagnata dalle onde di un’organizzazione perfetta, di equità, armonia, efficienza e lungimiranza. Controllo demografico, lavoro intenso ma ridotto a sole sei ore giornaliere, poche leggi ben chiare, ospedali ampi e accoglienti, nessuna proprietà privata, nessuno spreco né materiale, né spirituale, spregio dell’oro e delle pietre preziose, inutili tanto da essere state relegate nelle viscere della terra, nessun culto della persona: ingredienti ricchi e succulenti per chiamare i nostri giovani accademici a un dibattito che da subito li coinvolge appassionatamente.
Una prima riflessione: Utopia è organizzata in modo giusto e molto intelligente: tutto funziona perfettamente. Ma i ragazzi da subito, intuiscono che una macchina così perfetta funziona solo a condizione che non ci siano gli esseri umani. Perché noi, gli umani, non siamo perfetti, affatto. Anzitutto perché siamo diversi: i nostri vestiti, tutti colorati, servono a mostrare la differenza che portiamo dentro, vestirsi tutti allo stesso modo, come in Utopia, non andrebbe bene a nessuno di noi. Certo, si può dire che il difetto sia nell’umanità, si può persino immaginare che un ragazzo cresciuto in un mondo di uniformi e di uniformità non si porrebbe nemmeno il problema dell’abito; eppure, in un modo o nell’altro, la differenza dovrebbe emergere prima o poi. Ciò che i ragazzi intuiscono, questa strana differenza dell’essere umano, che non è mai indifferente, questa sorta di maledizione o benedizione della vita, è stata espressa con chiarezza da Jacques Lacan che nel libro Dei nomi-del-padre, scrive:
Ciò che funziona è il mondo. Il reale, invece, è ciò che non funziona. Il mondo va, gira bene, è la sua funzione di mondo. Per accorgersi che non c’è il mondo, vale a dire che ci sono cose che solo gli imbecilli credono che siano nel mondo, basta notare che ci sono cose che fanno sì che il mondo è immondo, se posso esprimermi così.
“Mondo” è un nome, ma è anche un aggettivo piuttosto sconosciuto ai ragazzi: lo cerchiamo sul dizionario e scopriamo che mondo, dal latino mundus, significa pulito, raffinato. Il mondo dunque – proprio come il cosmo che lo scorso anno abbiamo visto derivare dal greco kosmos cioè ordine, armonia – è tale perché pulito, elegante, privo di storture: il mondo gira bene, dice Lacan, e funziona; il reale invece non funziona e non funziona esattamente perché contiene elementi in-mundi immondi, non perfetti, non puliti. Il mondo è mondo, ma il reale è immondo. Ognuno di noi è insieme mondo e immondo: per questo un mondo perfetto non sarebbe nostro. Usciti dal garbuglio etimologico, i ragazzi comprendono il senso di questa provocazione e immediatamente la riconducono alla loro realtà scolastica: in ogni classe c’è un ragazzo, o più ragazzi che presentano difficoltà più o meno importanti. Il tessuto umano, nella classe, si compone di elementi eterogenei per storia di vita, capacità, volontà, impegno: funzionerebbe meglio la scuola se questo tessuto fosse invece omogeneo, liscio, senza neanche una piccola macchia? Si stupiscono i ragazzi, quando raccontiamo loro che ai nostri tempi non si riconoscevano i disturbi dell’apprendimento e nessuno di noi adulti ha avuto compagni con disabilità conclamate. Un tempo la difficoltà si teneva nascosta, non la si riconosceva e non le si dava un nome: si tirava avanti, in un’apparente buona funzionalità che però non corrispondeva certo al reale. Ma a tutti è chiaro che questa complessità non si risolve con una diagnosi. In fondo, si tratta di un’altra uniforme, può diventare un’etichetta appiccicata sui ragazzi in difficoltà. È giusto utilizzare metri di valutazione diversi, è sufficiente una tecnica appropriata? E come si concilia l’esigenza di giustizia con il bisogno di valutare? Temerari o cauti, drastici o possibilisti, tutti gli interventi sono interessanti e denotano attenzione e sensibilità sempre e comunque al tema del diverso, perché il mondo dei ragazzi, proprio come il nostro, è anche immondo e, se anche una soluzione non dovessimo trovarla, la vera svolta è occuparcene insieme. Ricomponiamo trama e ordito: ne viene fuori un tessuto bello e resistente proprio perché intrecciato in storie e capacità diverse. No, decisamente in Piccioletta Barca non abbiamo abiti e abitudini uguali. E ce ne facciamo un vanto.
Certo, non siamo diversi solamente in ciò che siamo, ma anche in ciò che abbiamo. Su questo Utopia affascina di più: l’idea che possa esistere un mondo in cui nessuno possiede nulla e tutto è condiviso, in cui non c’è né abbondanza, né povertà ci seduce. Sappiamo bene che non è facile realizzarlo e la mente di noi adulti va immediatamente alla rivoluzione bolscevica, ai suoi sogni infranti, all’abisso di povertà e di violenza che ha caratterizzato il totalitarismo sovietico. Lo raccontiamo ai ragazzi, perché non c’è differenza tra noi e Thomas More, ma nemmeno tra noi e il comunismo reale: sono le stesse tensioni, gli stessi desideri, ma anche le stesse tentazioni che da sempre assediano gli uomini e le donne. Forse è per questo che Thomas More non ci propone veramente un programma politico, ma uno specchio in cui guardare noi stessi e le nostre società. Ci stupisce, però, che il valore delle cose, delle cose che possediamo, non sia una questione così semplice. More schernisce il nostro mondo, in cui una cosa ha valore solo perché è rara: la terra di per sé ci fornisce spontaneamente ciò che più ha valore e noi andiamo a scavare per cercare le gemme più nascoste e più inutili. Non è detto che debba essere così. Spieghiamo ai ragazzi che una grande economista contemporanea, Mariana Mazzuccato, ha affrontato proprio questo tema nel suo recente libro Il valore di tutto. Dice che il nostro modo di pensare, per il quale «vali nella misura in cui ciò che fornisci è scarso» non è un fatto scontato: nella storia dell’economia molti hanno proposto giudizi di valore differenti. Chi lavora in Piccioletta Barca sa bene la fatica che si fa a spiegare il valore della cultura, che fa parte delle cose che, letteralmente, «non hanno prezzo». Utopia, questo mondo tanto impossibile da risultare strampalato, ci sta facendo pensare insieme: è il motivo per cui è stato creato.
C’è un particolare di quel mondo, però, che tutti amiamo e tutti vorremmo vedere realizzato. Non è un dettaglio e, questa volta, non richiama l’uniformità ma proprio la differenza. Nell’isola le punizioni per i crimini non sono uguali per tutti: uno schiavo viene punito sempre in modo meno severo di un cittadino istruito nella legge di Utopia. A quest’ultimo, infatti, è stata data la possibilità di pensare e abitare un mondo perfetto: a chi ha ricevuto di più viene chiesta una responsabilità in più. Su questo i ragazzi sono d’accordo: ci sono persone che hanno possibilità, ma la loro volontà è fragile e le sprecano; poi ci sono persone che vorrebbero fare ma non possono. Lorenzo Milani, uno dei patroni della Piccioletta Barca, sintetizzava così: «non c’è cosa più ingiusta che fare parti uguali tra diversi». Il senso della giustizia, tra i ragazzi, è molto forte; ma la giustizia non è quella cosa che non guarda in faccia a nessuno: la giustizia è la capacità di guardare all’altro, alla sua differenza, è una lotta all’indifferenza. Trovare in loro questa virtù, così rara di questi tempi, è una grande speranza per tutti.
